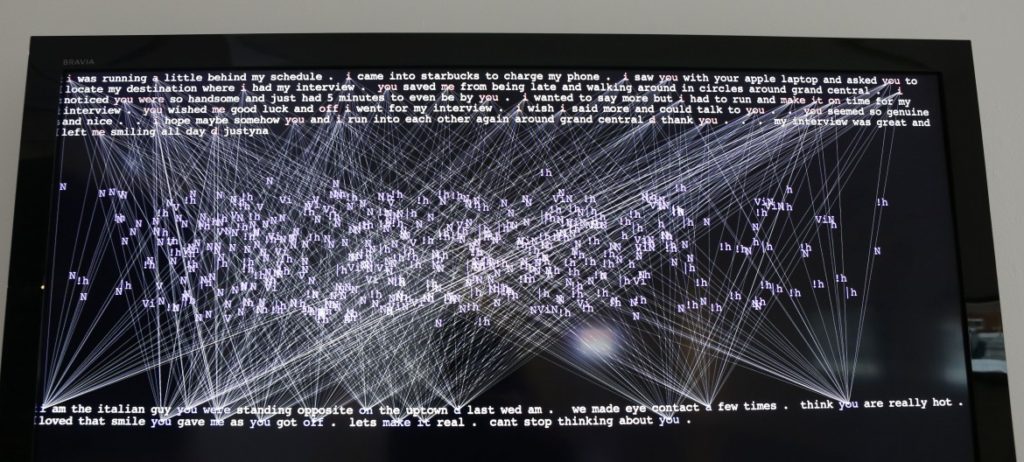by
originally published on Il Manifesto, 24 April 2020
Big Data e Covid. La pandemia sta facendo emergere fenomeni e caratteristiche della società dei dati che, in circostanze di emergenza come quelle di queste settimane, rischiano di concretizzare quelli che—fino a poco fa—potevano essere considerati solo scenari estremi, conseguenze inaspettate, o effetti collaterali
La pandemia globale COVID-19 è la prima a manifestarsi su un piano così esteso e in modalità così tanto gravi in una fase avanzata della cosiddetta “società dei dati”. Ci troviamo, di fatto, in un momento spartiacque per il nostro stesso definire cosa significhi vivere un’epoca di pressoché totale trasformazione in dati delle attività umane in qualsiasi ambito.
Una situazione estrema come quella che stiamo vivendo in queste settimane di lockdown quasi totale inevitabilmente mostra tutte le sfumature di questo fenomeno, dalle più virtuose alle più potenzialmente inquietanti.
Non esiste nella storia recente un avvenimento di portata simile che possa competere con l’attuale stato di pandemia globale da un punto di vista di definizione del contemporaneo. Bisogna tornare indietro di due decenni, fino all’11 settembre 2001, per ritrovare un altro momento paragonabile di onnicomprensivo stress-test degli assunti culturali e dei fondamenti della nostra società nel complesso. Il 2001 e il 2020, però, hanno pochi punti di contatto per quanto riguarda gli ecosistemi tecnologici, le infrastrutture digitali e, di conseguenza, gli impatti sociali e politici di questi assetti tecnologici.
La società dei dati mette al centro la produzione di dati e il loro uso per creare valore aggiunto, dalla gestione del traffico al miglioramento dei servizi pubblici, dalla pubblicità personalizzata sul digitale fino alle app di contact tracing contro il COVID-19.
Il paradosso è che, anche in circostanze normali, siamo noi stessi a generare la maggior parte di questi dati, attraverso per esempio gli smartphone, le carte di credito, lo shopping online e i social media. La monetizzazione su larghissima scala dei dati relativi alle nostre preferenze e comportamenti ha generato il valore su cui si sono costruite società come Google e Amazon che hanno nell’analisi e nella predizione i loro maggiori punti di forza, o i loro monopoli.
Noi cittadini produciamo però dati anche ricorrendo al sistema sanitario pubblico o semplicemente passeggiando nelle nostre città, oramai popolate da una miriade di videocamere di sorveglianza o sistemi “intelligenti” di riconoscimento facciale. Molti di questi dati finiscono poi in mani private, anche quando apparentemente sembrano essere sotto il controllo di entità statali: spesso i server sono gestiti da imprese come Accenture, IBM o Microsoft.
Questa geografia variabile di dati, infrastrutture, e entità pubbliche e private è un cocktail potenzialmente esplosivo, soprattutto per la sua scarsa trasparenza verso gli utenti e i rischi per la privacy individuale e collettiva. La società dei dati è infatti anche la culla di quello che l’economista americana Shoshana Zuboff ha chiamato “capitalismo della sorveglianza”, il cui motore è la mercificazione delle informazioni personali anche a costo di ridurre la nostra capacità di agire in modo indipendente e compiere libere scelte. In altre parole, è il nostro stesso essere cittadini che cambia, e non necessariamente in meglio.
Il dramma a più livelli—dall’umano all’economico al sociale—scatenato dalla pandemia COVID-19 contribuisce a mostrare i lati più oscuri e controversi del sistema di mercificazione dei dati.
La pandemia sta infatti facendo emergere fenomeni e caratteristiche della società dei dati che, in circostanze di emergenza come quelle di queste settimane, rischiano di concretizzare quelli che—fino a poco fa—potevano essere considerati solo scenari estremi, conseguenze inaspettate, o effetti collaterali.
Per quelli che possono essere gli ambiti di interesse delle scienze sociali, ci sono almeno quattro diverse aree in cui la pandemia sta agendo da acceleratore di dinamiche potenzialmente pericolose fin qui rimaste più in nuce.
Al di fuori di ogni determinismo—sia tecnologico che epidemiologico—sono fin qui emerse almeno quattro distinte tendenze. Queste sono il positivismo acritico, l’information disorder, il vigilantismo e la normalizzazione della sorveglianza: quattro nemici resi quasi invisibili dal dramma umano della pandemia, ma che feriscono la collettività quasi quanto il virus. E sono destinati ad avere conseguenze di lungo termine a dir poco pericolose. Vediamoli assieme.
Il positivismo acritico
Il primo nemico invisibile è associato ad un verbo di uso comune, “contare”, un’azione che in questi giorni ci viene giustamente presentata come un alleato. “Facciamo parlare i numeri”, si sente spesso dire. Chi non rimane col fiato sospeso in attesa delle tabelle della protezione civile che ci comunicano il numero di morti, di guariti, di ospedalizzati? Il contare, e ancora di più il contarsi, è per ogni società un momento di presa di coscienza importante: basti pensare ai censimenti che hanno un ruolo cruciale nella definizione dello stato nazione. Per di più contare ha che fare con l’essenza stessa delle pandemie: i grandi numeri.
Di norma, tendiamo a credere di più ai dati statistici che alle parole, poiché vi associamo una sorta di verità di ordine superiore. Si tratta di un fenomeno noto anche come “dataism”, dataismo, un’ideologia che ripone eccesiva fiducia nel potere soluzionista e predittivo dei dati.
La fede nei numeri ha radici lontane, da rintracciare nei giorni del positivismo del 19esimo secolo, che postulava la fiducia nella scienza e nel progresso scientifico-tecnologico. Nel suo “Discorso sullo spirito positivo” (1844), il filosofo Augusto Comte spiega come il positivismo riporti al centro “il reale, in opposizione al chimerico”, e come si prefigga di “opporre il preciso al vago”, configurandosi come “il contrario di negativo”, vale a dire identificando un atteggiamento propositivo di fiducia nel futuro.
Di sicuro, riportare i fatti concreti al centro della narrazione del virus e della ricerca di soluzioni non può che essere cosa buona e giusta dopo una stagione buia per la scienza, in cui sono stati messi in questione perfino i vaccini. Purtroppo, però, la fiducia nei numeri è spesso mal riposta poiché, come si è spesso detto in queste settimane, i dati ufficiali tendono a raccontare una porzione limitata e spesso fuorviante della realtà pandemica.
Ciononostante, i numeri e i dati sono al cuore della narrazione del virus. Si tratta, però, di una narrazione poco accurata, spesso decontestualizzata, e non per questo meno ansiogena. Il risultato è un positivismo acritico che tende ad ignorare il contesto e non spiega come si faccia di conto e perché. Decisioni che coinvolgono intere nazioni vengono prese e giustificate sulla base di numeri che non hanno, però, a disposizione dati necessariamente affidabili.

L’information disorder nella pandemia
Il contesto informazionale di una pandemia è stato equiparato ad un’”infodemia”, un’espressione utilizzata in primis dalla stessa Organizzazione mondiale della sanità per definire circostanze in cui vi è una sovrabbondanza di informazioni—accurate o meno—che rendono molto difficile orientarsi tra le notizie o anche solo distinguere le fonti affidabili da quelle che affidabili non sono. La pandemia è di conseguenza anche una situazione particolarmente rischiosa per quanto riguarda il diffondersi di varie tipologie di “information disorder”—letteralmente disturbi dell’informazione—come varie forme di disinformazione o misinformazione.
Nell’infodemia da COVID-19 la cattiva informazione si è manifestata in vari modi. Il Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ) dell’Università di Oxford ha pubblicato uno dei primi studi sulle caratteristiche del fenomeno in questa pandemia, concentrandosi su un campione di notizie in lingua inglese vagliate da iniziative di fact-checking come il network non profit First Draft. Lo studio, che è un primo tentativo esplorativo di analisi del problema, rivela come la varietà delle fonti di disinformazione sulla pandemia possano essere sia “top-down” (quando sono promosse dalla politica o da altre personalità pubbliche) o “bottom-up”, ossia quando partono dagli utenti comuni.
Se la prima tipologia rappresenta il 20% del totale del campione analizzato dal RISJ, è anche vero però che la disinformazione top-down tende a generare molto più buzz sui social media rispetto a quanto prodotto dal basso. Scrive il RISJ, inoltre, che la fetta più grande della misinformazione emersa in queste settimane sarebbe costituita da contenuti “riconfigurati”, modificati ovvero in alcune loro parti. Solo una minoranza (il 38% circa) sarebbe invece composta da contenuti completamente inventati ex novo.
Lo studioso Thomas Rid, uno dei massimi esperti mondiali di campagne di disinformazione nell’ambito della sicurezza nazionale (alla cui storia ha dedicato un libro molto atteso e di prossima pubblicazione, “Active Measures”), ha fatto notare inoltre sul New York Times come la situazione di pandemia possa costituire anche un terreno particolarmente fertile per potenziali operazioni di “information warfare” volte a creare confusione e tensioni nelle opinioni pubbliche dei paesi colpiti, sulla scia di quanto si è visto negli Usa durante le elezioni presidenziali del 2016. Non va nemmeno dimenticata la misinformazione che sfocia nel razzismo e alimenta pulsioni xenofobe, come la falsa notizia, circolata in vari ambienti, che vorrebbe gli africani immuni al virus.

Il vigilantismo (digitale e non)
Di questi tempi, molti runner si sono sentiti apostrofare malamente, e in alcuni casi sono stati anche aggrediti fisicamente, da altri cittadini indispettiti dal potenziale pericolo per la salute pubblica che può rappresentare un individuo in libera uscita.
Persone che si stavano recando al lavoro hanno raccontato di essere stati vittime di ingiurie di vario tipo per non essere “stati a casa”. Innumerevoli video sono stati caricati sui social media con lo scopo di denunciare chi sarebbe presumibilmente andato a spasso infischiandosene del lockdown. Questo fenomeno è conosciuto in criminologia e sociologia come “vigilantismo”, come ha spiegato il criminologo Les Johnston già nel 1996.
Il vigilantismo riguarda privati cittadini che volontariamente assumono ruoli che non competono loro, come quello di controllo del comportamento degli altri e la relativa denuncia pubblica delle malefatte altrui, vere o presunte. Con le sue azioni di difesa delle norme sociali, il vigilante cerca di offrire delle garanzie di sicurezza a sé stesso e agli altri.
L’avvento dei social media e dei dispositivi mobili ha favorito la diffusione su larga scala di un “vigilantismo digitale” che, come racconta il ricercatore dell’Università di Rotterdam Daniel Trottier, ha lo scopo di attaccare e svergognare l’autore del mancato rispetto delle regole attraverso un’esposizione al pubblico ludibrio, che è spesso duratura e irrispettosa della privacy altrui, e alimenta aggressività e sentimenti di rivalsa.
Se il fenomeno è tipico di momenti storici in cui l’ordine costituito è a rischio, o viene percepito come tale, la sua comparsa e diffusione nei giorni dell’emergenza Coronavirus appare quasi inevitabile. Il vigilantismo digitale da COVID-19 è però particolarmente rischioso, per almeno due ragioni. Anzitutto, questo bisogno di odiare “chi esce da casa”, crea esclusione e stigma sociale, additando ed esponendo individui sulla base di indizi puramente visivi che non possono discriminare tra chi effettivamente rompe le regole e chi invece ha una buona ragione per farlo (per esempio, si sta recando al lavoro).
Questa pericolosissima creazione di “nemici del popolo” sfocia in danni ingenti a livello psicologico—dal senso di solitudine all’incomprensione al desiderio di ritorsione—che molto probabilmente sopravvivranno all’emergenza Coronavirus.
Questo fenomeno finisce inoltre per giustificare simili comportanti trasgressivi, sulla base dell’errato ragionamento che “se lo fanno gli altri, lo posso fare pure io”. In secondo luogo, il vigilantismo digitale o meno divide la collettività, con gravi e duraturi effetti a livello di divisioni sociali tra presunti buoni e cattivi, tra meritevoli e non. Finisce per intaccare la narrazione tanto necessaria di una comunità unita forte proprio della sua unità, in grado di fronteggiare l’emergenza in maniera razionale, proprio nel momento in cui vi è un bisogno estremo di sapere che il sacrificio individuale alimenta lo sforzo collettivo.

Privacy e normalizzazione della sorveglianza
La pandemia ha anche riacceso il dibattito sul ruolo della privacy nella società dei dati e, in particolare, in un contesto di emergenza sanitaria come quello di queste settimane. Da più parti, seguendo l’esempio—o i presunti “modelli”—offerti da alcuni paesi asiatici variabilmente democratici o non democratici come Cina, Singapore e Corea del Sud, è stato chiesto di intraprendere soluzioni tecnologiche di sorveglianza e monitoraggio digitale per cercare di rallentare la diffusione del virus tramite il monitoraggio digitale dei cittadini, in varie forme.
Anche in Europa, diversi governi hanno iniziato a lavorare a possibili soluzioni tecniche e, nel complesso, il dibattito si è orientato verso lo sviluppo di applicazioni di “deconfinamento” che potessero sfruttare varie funzioni degli smartphone per fare “contact tracing”, ovvero monitorare i contatti sociali delle persone infettate o potenzialmente esposte a focolai di contagio.
Ad accumunare queste soluzioni, ad ogni modo, sono le complesse e pericolose ripercussioni in termini di diritti, privacy e sicurezza, temi che è fin troppo semplice perdere di vista se si guarda alla tecnologia con lenti eccessivamente deterministe, soluzioniste o dal punto di vista del “positivismo acritico” di cui sopra.
Difficile riassumere il polifonico dibattito italiano sulla questione dell’app “Immuni” scelta dal governo a questo scopo, ma numerosi elementi indicano come si sia cercato da subito di far passare la privacy come un ostacolo per l’attuazione di misure fondamentali.
Questo si è visto all’estremo in Francia, il primo paese a ufficialmente chiedere a Google e Amazon di allentare le misure di protezione della privacy per facilitare l’adozione di app di tracciamento dei contatti. In Italia, “Immuni” andrà nella direzione di un approccio basato su Bluetooth e decentralizzazione, certamente meno invasivo di altre opzioni che sono state sul tavolo delle varie task force governative, ma alcune indicazioni interessanti emergono dal dibattito che ha accompagnato queste decisioni.
Per quanto questa soluzione sembrerebbe sulla carta meno invasiva di altre, anche in questo caso rimangono aperte diverse questioni di opportunità. Claudio “Nex” Guarnieri, uno dei massimi esperti mondiali di sicurezza informatica, ha commentato le varie soluzioni tecniche avanzate, ricordando come anche il Bluetooth non offra comunque garanzie in termini di efficacia.
Le scienze sociali e vari studi sul giornalismo e sulla sorveglianzamostrano come la “normalizzazione” della sorveglianza sia un fenomeno frequente nei dibattiti pubblici sul tema. Qualcosa di simile si è avvertito anche nel dibattito italiano ed europeo nel mezzo della pandemia: i timori degli esperti (sia tecnici che legali) sono stati speso bollati sbrigativamente come problemi di secondo piano, mentre si è fatta passare la falsa dicotomia tra privacy e difesa della salute pubblica, come se la prima invariabilmente ostacolasse la seconda. In realtà, come ha scritto anche lo scrittore e autore dell’acclamato Homo Deus (2017) Yuval Noah Harari sul Financial Times, porre i due temi come in antitesi è scorretto, in quanto non si dovrebbe chiedere ai cittadini di scegliere tra due diritti fondamentali che tra di loro non si auto-escludono di certo.
La domanda da porsi è a quanti e quali diritti siamo e saremo disposti a rinunciare—anche solo in parte—e per quali obiettivi? Una visione troppo deterministica delle potenzialità di queste soluzioni tecniche potrebbe anche portare a sopravvalutare la loro effettiva capacità di essere d’aiuto in questo scenario.
Troppo spesso, inoltre, si è banalizzato il discorso attorno alla privacytentando, in modo disonesto, di mettere sullo stesso piano le abitudini online degli utenti—spesso frivole—con un programma di monitoraggio statale della salute pubblica. La privacy non è morta, come si è invece letto da più parti, e per quanto in parte erosa dal più che problematico sfruttamento commerciale in essere sul web, non si può ridurre questo dibattito al novero delle scelte individuali, azzerandolo con un click.
L’altra questione a restare aperta è infine quella del ritorno alla normalità: a emergenza finita, come assicurarsi che le tecnologie di tracciamento e infrastrutture di controllo pensate per tempi di crisi vengano effettivamente disattivate (e i loro dati cancellati)? Su questo punto si è espressa in modo chiaro anche la Commissione Europea, che si è pronunciata con alcune raccomandazioni e una toolbox, auspicando per gli stati membri un approccio pan-europeo nella difesa della privacy e della protezione dei dati, oltre a standard tecnici condivisi e quanto più decentralizzati.
Il grande assente nello scenario italiano rimane però il dibattito parlamentare sulla questione—come invece sta avvenendo per esempio in Olanda proprio mentre scriviamo—che pur sarebbe doveroso per assicurare il controllo democratico, la accountability e il rispetto di norme e valori democratici di base in scelte tanto delicate.
Gli anticorpi
Ma come si combattono questi quattro nemici insidiosi? Purtroppo la soluzione non è né semplice né immediata. E non esiste (né mai esisterà) un vaccino capace di magicamente immunizzare la collettività contro il positivismo acritico, l’information disorder, il vigilantismo digitale e la normalizzazione della sorveglianza. Possiamo però lavorare sugli anticorpi e fare in modo che si diffondano il più possibile nelle nostre comunità. La società dei dati ha bisogno di utenti critici e consapevoli, che sappiano usare e contestualizzare gli strumenti sia digitali che statistici, che sappiano comprendere i rischi che invariabilmente vi sono associati ma anche cavalcarne i potenziali benefici. E che possano aiutare le fasce meno digitalizzate della popolazione a navigare la propria presenza digitale.
In questo processo assume un ruolo centrale la cosiddetta “data literacy”, ovvero l’alfabetizzazione informatica estesa alla società dei dati. Tale alfabetizzazione deve prendere in considerazione la questione della cittadinanza nell’era dei big data e dell’intelligenza artificiale e deve metterci in grado di compiere scelte consapevoli per quanto riguarda i contorni della nostra azione sul web, comprese le complesse considerazioni in materia di protezione dei dati personali.
Deve aiutarci a distinguere tra le fonti di informazione e a districarci tra gli algoritmi di personalizzazione dei contenuti che inficiano la nostra libera azione sul web. La sfida è aperta ma anche particolarmente urgente se è vero che l’Italia è il fanalino di coda tra i 34 paesi OEDC (Organization for Economic Co-Operation and Development) per quanto riguarda l’alfabetizzazione digitale. Una ricerca recente (2019) proprio dell’ OEDC ha rivelato come solo il 36% degli italiani sia in grado di fare “un uso complesso e diversificato di internet” —il che crea un terreno fertile per i quattro nemici che abbiamo identificato.
Il mondo dell’educazione ha certamente un ruolo chiave da giocare, affiancando una rinnovata educazione alla cittadinanza sul web alla bistrattata educazione civica. Per questo serve una seria formazione del corpo docente, ma servono anche dei fondi dedicati per strumenti, infrastrutture e preparazione. Si tratta però di un progetto di medio e lungo termine, che difficilmente si potrà attuare durante la pandemia. La questione da non perdere di vista è che il mondo “post-Coronavirus” è in costruzione proprio ora, nel vortice della pandemia.
Le scelte intraprese oggi avranno un inevitabile impatto sugli scenari futuri della società dei dati. Più che mai, a dettare queste scelte deve essere un approccio inclusivo, trasparente e onesto per non trovarsi in un futuro dove a dominare sono “scatole nere” tecnologiche, oscure, discriminanti e potenzialmente anti-democratiche.
Gli autori
Philip Di Salvo è ricercatore post-doc e docente presso l’Istituto di media e giornalismo dell’Università della Svizzera italiana (USI) di Lugano. Si occupa di leaks, giornalismo investigativo e sorveglianza di Internet. “Leaks. Whistleblowing e hacking nell’età senza segreti” (LUISS University Press) è il suo ultimo libro.
Stefania Milan è professoressa associata di New Media e Digital Culture presso l’Università di Amsterdam, dove insegna corsi di data journalism e attivismo digitale, e gestisce il progetto di ricerca DATACTIVE, finanziato dal Consiglio Europeo della Ricerca (Horizon2020, Grant Agreement no. 639379).